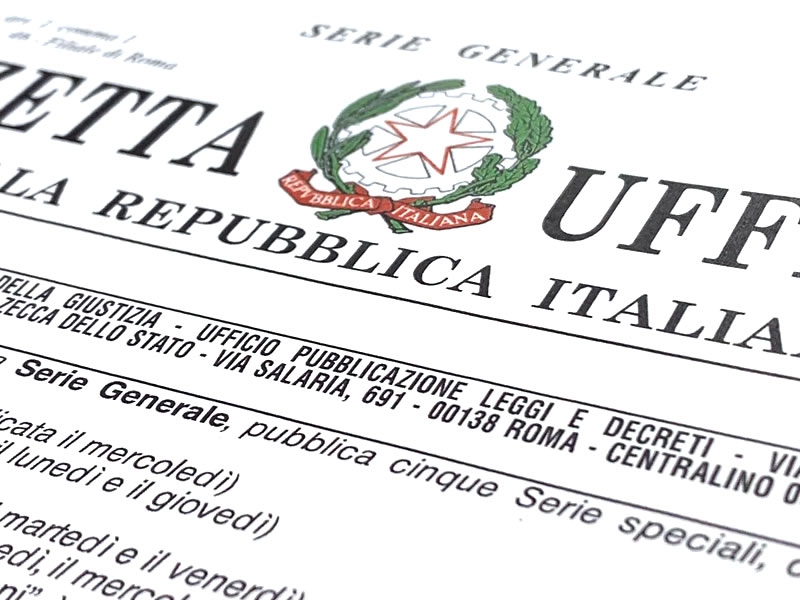di Valentina Moriello (Uiltrasporti Campania)
Da oltre un decennio, il tema delle concessioni balneari in Italia è un vero e proprio nodo gordiano.
Nel nostro paese, infatti, le concessioni demaniali marittime per attività ricreative e turistiche sono prive di una legge che definisca le modalità per rinnovarle nel rispetto della concorrenza richiesta dalla direttiva europea Bolkestein e senza l’automatico rinnovo agli stessi titolari delle concessioni.
Il continuo rinvio delle procedure ad evidenza pubblica per l’assegnazione delle spiagge, imposte dalla Bolkestein, ha creato un’incertezza cronica nel settore, con ripercussioni negative su imprese, amministrazioni locali e cittadini, dando vita ad un balletto politico senza fine. Ma soprattutto ha creato una vera e propria privatizzazione delle spiagge, beni pubblici per eccellenza, garantendo, di fatto, ai concessionari una situazione di monopolio: le spiagge sono diventate “beni di famiglia”.
E da quando la direttiva è stata recepita nel 2010, i governi di tutti i colori politici che si sono alternati (Berlusconi, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi) hanno preferito rinviare una soluzione definitiva.
Governo dopo governo, si sono cercate scorciatoie e interpretazioni creative della normativa europea. L’ultimo tentativo è stato quello di dimostrare, attraverso una mappatura delle coste, comprese zone impraticabili, che le spiagge libere in Italia sono sufficienti a soddisfare la domanda, evitando così di dover indire gare per le concessioni già esistenti. Tuttavia è di lapalissiana evidenza che le spiagge libere in molte regioni italiane sono sempre meno, spesso situate in aree degradate o difficilmente fruibili, o addirittura assenti. Inoltre, la definizione di “scarsità della risorsa”, che è ancora oggetto di dibattito, lascia ampi margini di interpretazione.
Anche l’attuale governo Meloni, lo scorso dicembre, ha allungato ulteriormente i tempi prorogando le attuali concessioni balneari di un altro anno, ovvero fino alla fine del 2024, creando un’ulteriore situazione di stallo. La Commissione europea, stanca delle continue violazioni italiane, ha aperto una procedura di infrazione e ha chiesto chiarimenti urgenti.
A pagare le conseguenze dell’inerzia che ha contraddistinto il nostro “sistema paese” sono stati sia gli attuali concessionari che i nuovi imprenditori interessati ad investire, entrambi privi di certezze nel futuro; ma a trovarsi in difficoltà sono state soprattutto le Amministrazioni locali che si sono ritrovate a decidere in autonomia sul da farsi con i titoli concessori in scadenza. Molte Amministrazioni, infatti, come satelliti impazziti, sono partite in maniera disomogenea: alcune prorogando i titoli in scadenza, altre bandendo procedure concorrenziali inventandosi criteri selettivi.
Ma in questo clima ancora incerto e “nebuloso”, in cui la soluzione non può essere un persistente rinvio, l’Europa continua ad evidenziare la natura pubblica del nostro mare e delle nostre spiagge: la Corte di Giustizia Europea, infatti, con la sentenza dell’11 luglio 2024 nella causa C-598/22, ha offerto un’interpretazione chiara e definitiva dell’articolo 49 del Codice della Navigazione, confermando la natura precaria e revocabile delle concessioni demaniali marittime.
La Corte, infatti, ha sancito che le spiagge sono un bene comune inalienabile e ne ha condannato l’appropriazione indebita da parte di privati. La sentenza, che stronca le proroghe automatiche delle concessioni balneari e legittima l’esproprio delle opere abusive, può essere intesa come un’opportunità per rilanciare un modello di gestione delle spiagge più sostenibile e inclusivo.
Ma l’Italia, lontana, purtroppo, dalla visione “europeista” del nostro mare quale bene pubblico e fruibile da tutti, ha provato ad elaborare una nuova proposta, bocciata dalla Commissione Europea nei giorni scorsi, con la previsione di ulteriori proroghe delle attuali concessioni balneari, e del riconoscimento di un indennizzo e di una prelazione per gli attuali concessionari.
Bruxelles, in un primo momento, ha respinto quanto suggerito da Palazzo Chigi, ma tra Roma e la Commissione Europea è intercorso un vero e proprio braccio di ferro che sembra, inaspettatamente, essere terminato venerdì scorso dopo difficili negoziazioni. Dal vertice di maggioranza sarebbe emersa una sostanziale intesa su un testo messo a punto dal governo, con il ruolo centrale del ministero degli Affari Ue, dopo un lungo negoziato con Bruxelles. L’accordo, che potrebbe essere inserito all’interno del decreto legge salva-infrazioni, prevederebbe la proroga delle concessioni turistico ricreative fino a settembre 2027. Le Amministrazioni locali, comunque, se lo vorranno, potranno anticipare i tempi delle nuove procedure di affidamento.
Un’impasse amministrativa, questa delle proroghe, che sembra non avere mai fine; tuttavia in questo ginepraio burocratico ci sono alcuni aspetti di cui, “intenzionalmente”, nessuno parla: il primo è che il settore turistico ricreativo non è rappresentato solo dai balneari, che sono solo una parte delle imprese che occupano il demanio ad uso turistico ricreativo, eppure sembra che siano proprio i balneari a fare da traino per tutti; inoltre, non ci si deve dimenticare dell’eterogeneità della costa italiana con le sue specifiche realtà e le relative eccezioni che incideranno in modo sostanziale sulle diverse procedure ad evidenza pubblica da espletarsi.
Per di più il confronto con i nostri vicini europei mette in evidenza una situazione anomala per quanto riguarda la fruizione delle spiagge in Italia. Nel nostro paese è difficile trovare lidi non attrezzati perché la maggior parte della costa delle località marittime è occupata da stabilimenti balneari; in Francia, Spagna, Portogallo o Grecia, ci sono dei chioschi che affittano lettini e ombrelloni, ma nessuno impedisce il libero passaggio delle persone.
Tutto questo è sicuramente determinato da una differenza culturale nell’approccio al mare. Nei Paesi citati, il mare è visto come un bene comune da tutelare e condividere, mentre in Italia prevale spesso una visione più privatizzante.
Sembrerebbe, pertanto, necessario anche un cambio di rotta per superare una situazione che penalizza sia i cittadini che l’ambiente e per tutelare il diritto di tutti noi di godere gratuitamente e liberamente del bene demaniale spiaggia e di conseguenza del mare, un bene che come sappiamo è catalogato come “res communes omnium” ovvero bene comune di tutti.