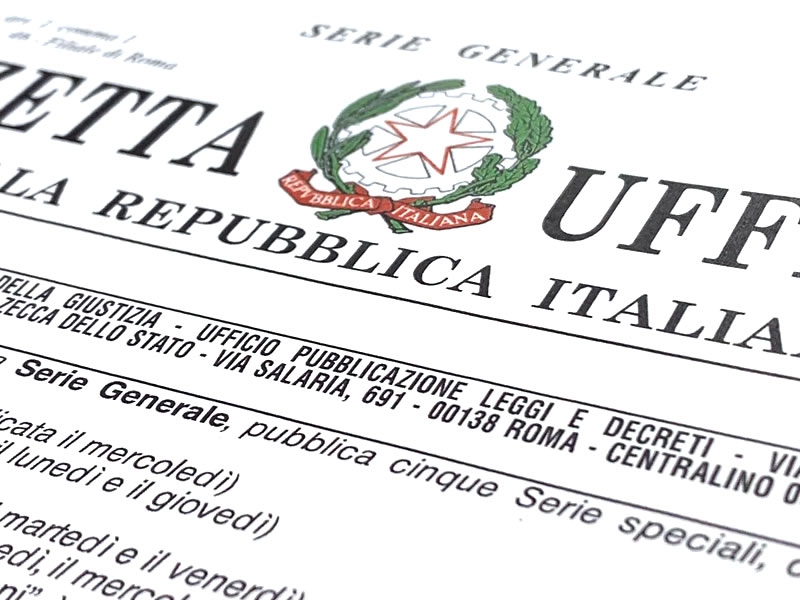Tra innovazione e diritti, la mobilità alla prova dell’automazione
Di Enrico Casadei – Uil Ravenna
Negli ultimi anni, le strade di città come San Francisco, Phoenix o Pechino hanno iniziato a popolarsi di veicoli che sembrano usciti da un film di fantascienza: automobili senza autista, capaci di muoversi nel traffico urbano, trasportare passeggeri e gestire una corsa dall’inizio alla fine in totale autonomia. Sono i robotaxi, il simbolo più evidente di una trasformazione tecnologica che promette di rivoluzionare la mobilità urbana, ma che al tempo stesso solleva interrogativi profondi su sicurezza, occupazione e diritti dei lavoratori.
Un robotaxi è un’auto a guida completamente autonoma, gestita da una piattaforma digitale (come ad esempio solo per citarne alcune Waymo, Tesla, Baidu), che funziona in modo simile a un servizio di taxi o di ride-sharing: l’utente prenota una corsa tramite app, l’auto arriva da sola e lo porta a destinazione, senza alcun conducente a bordo.
Negli Stati Uniti, i primi servizi commerciali sono già operativi: Waymo (controllata da Alphabet, la società madre di Google) gestisce robotaxi a Phoenix e San Francisco, mentre Cruise, di General Motors, ha dovuto sospendere le proprie attività dopo alcuni incidenti e problemi regolatori. In Cina, il colosso Baidu gestisce migliaia di corse giornaliere con i suoi veicoli autonomi a Wuhan e Pechino.
In Europa, invece, le sperimentazioni sono ancora in fase iniziale: Parigi, Monaco e Londra stanno testando servizi limitati.
I sostenitori dei robotaxi descrivono un futuro in cui la mobilità sarà più sicura, economica e sostenibile. Le auto autonome, dicono, ridurranno drasticamente gli incidenti causati da errore umano (responsabili di oltre il 90% dei sinistri), elimineranno le ore di inattività dei veicoli, e permetteranno una gestione più efficiente del traffico e dei consumi energetici.
In teoria, un sistema di trasporto automatizzato potrebbe anche migliorare il servizio pubblico, integrandosi con autobus, metropolitane e treni per coprire le cosiddette “ultime miglia” in modo rapido e flessibile.
Ma la realtà, per ora, è molto più complessa. I robotaxi incontrano ancora limiti tecnici significativi: difficoltà nel riconoscere comportamenti imprevedibili di pedoni e ciclisti, incapacità di reagire a situazioni d’emergenza non codificate, e problemi etici nella gestione delle decisioni automatiche in caso di incidente. Alcuni episodi, come quello di un robotaxi Cruise che nell’ottobre di due anni fa ha trascinato una persona dopo un impatto, hanno riacceso il dibattito sulla reale sicurezza di questi veicoli.
Dal punto di vista dei lavoratori dei trasporti, la questione più urgente è quella occupazionale. Il settore taxi, il noleggio con conducente e persino il trasporto merci leggero potrebbero subire nei prossimi anni un impatto enorme dall’automazione. Secondo alcune stime internazionali, tra il 10 e il 20% dei posti di lavoro nel trasporto su strada potrebbero essere a rischio entro il 2040, se la guida autonoma dovesse diffondersi su larga scala.
Non si tratta solo di “posti persi”: si tratta anche di trasformazioni radicali delle competenze e delle condizioni di lavoro. Le piattaforme digitali tendono a sostituire rapporti di lavoro stabili con modelli più frammentati, basati su algoritmi e flessibilità estrema.
Nel caso dei robotaxi, il rischio è che il valore del lavoro umano venga completamente espulso dal processo produttivo: niente più autisti, nessuna interazione diretta con il cliente, e una gestione completamente automatizzata dei turni, delle rotte e dei costi.
Altro tema cruciale è quello della responsabilità. Chi risponde in caso di incidente causato da un robotaxi? Il produttore dell’auto? La società che gestisce il software? L’ente pubblico che ha autorizzato la sperimentazione?
La legislazione attuale, in Italia come in Europa, è ancora in evoluzione. In assenza di regole chiare, il rischio è che — come spesso accade — la colpa finisca per ricadere sugli anelli più deboli della catena, o che le aziende riescano a eludere la responsabilità grazie a cavilli tecnici o giuridici.
Dal punto di vista dei lavoratori dei trasporti, il robotaxi non rappresenta solo una minaccia di sostituzione, ma anche una ridefinizione del ruolo sociale del trasporto. L’autista non è solo colui che guida: è anche un punto di riferimento per la sicurezza dei passeggeri, una figura che conosce il territorio, che interviene in caso di necessità, che rappresenta una presenza umana in un servizio pubblico. Eliminare questa dimensione significa trasformare la mobilità in un servizio impersonale, gestito da algoritmi e centrali di controllo, dove tutto è ottimizzato ma nulla è umano.
Eppure, anche all’interno del mondo del lavoro, l’automazione può essere vista come un’opportunità se governata collettivamente: può migliorare le condizioni di sicurezza, ridurre i turni usuranti, e aprire nuovi spazi professionali nella manutenzione, nella gestione dei dati e nei servizi di supporto. Il punto è che tutto ciò non accadrà spontaneamente: richiede politiche pubbliche, investimenti e una contrattazione collettiva lungimirante.
Il dibattito sui robotaxi è, in sostanza, il riflesso della grande sfida tra l’efficienza della tecnologia e l’esigenza di tutelare i diritti dei lavoratori. L’automazione può essere un alleato del progresso solo se guidata da una visione sociale, non da interessi puramente economici. Per questo il sindacato ha un ruolo decisivo: non quello di opporsi al cambiamento, ma di orientarlo.
Serve chiedere trasparenza sui progetti di sperimentazione, partecipazione alle decisioni che riguardano la mobilità pubblica e privata, e garanzie concrete per chi i lavoratori del settore.
L’innovazione che lascia indietro i lavoratori non può essere considerata progresso. Il vero futuro dei trasporti sarà quello capace di unire tecnologia e giustizia sociale, mettendo al centro le persone, non i soli algoritmi.